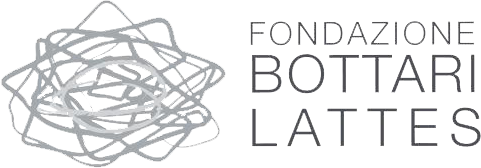Mario Lattes, L’io spezzato

Acqui Terme, Galleria Massucco (4 ottobre – 9 novembre 2013).
Mostra e catalogo a cura di Marco Vallora
E per non essere didascalici: didascalie. Le più assottigliate ed acuminate possibili, ritagliate e scollate tra loro: ‘dida’ come si dice nel gergo editorial-giornalistico, senza perdere tempo, rastremando.
Che la rapsodicità della materia ectoplasmatica di queste tele notturnine (mettendo insieme la notte ed il temperamento saturnino, però come striminzito nel diminutivo infantile fiabesco) sia dunque omaggiata con il ricorso alla frammentazione, alla rapidità verdiana delle suggestioni immediate, folgorante, all’appuntabilità, irrelata. Ronzandoci sopra, come insetti molesti, magari penetrando dal basso, da un foro tarlato della cornice, guardando rovesciati, verso l’in su.
Anzi, l’autore solo, in affollata solitudine, infilzato tra i molti vaganti. Come la marionetta spettrale, che accompagna il titolo, qualche pagina monte: a coperchio. Un titolo rubato ad un classico dell’inquietudine, para-pirandelliano, con un’eufonia vellicata e titolistica, fin troppo facile, eppure solutiva, come un acido d’acquatinta. Ove si scioglie la prosopopea autistica ed autoritrattistica dell’artista, che si mette in scena e subito si bastona, ammaccandosi, come un burattino coriaceo e predestinato.
Il primo punctum, che ti sollecita e colpisce, come un freccetta ben indirizzata, in questo primo quadro di recezione, è proprio quello della ‘pendenza’, della sbilanciata crollevolezza, che viene verso di noi, implicandoci. L’accesa e mediterranea ‘passione’ di Rosso di San Secondo si congela infatti, pedemontanamente, in una sorta di ossessione diffusa e scatolante, per dirla col Testori, claustrofobicamente spalmata, in quei ritmici scaffali di accidia, disseminati ovunque. L’Artista vien meno, pencola, tentenna, s’immobilizza: un crollo sbilanciato che non smette, che attraversa la tela come un fiotto schizzato di sangue e subito incrostato. Muore, non essendo più vivo. Marionetta di se stesso tra altre marionette, infilzato di sbieco e di straforo, fatto di carne di legno e reverente gibus, in testa,
panciotto bistrato, forse piuma alla bombetta post-medievale e gli occhi bistrati d’ostrica, da chansonnier mancato e stanco, lunare, alla Laforgue, poeta azzoppato, che scrive a sé medesimo. Ed è probabilissimo che Lattes conoscesse sia l’autoriferito sonetto ‘A se stesso’ di Leopardi, che il journal à soi même di Odilon Redon. Si rappresenta, ma non si ama. Non è certo frequente, anzi, quasi un apax, quest’inedito taglio di prospettiva, di rappresentarsi come dall’alto in basso, procombendo, sviato, parallelo allo sguardo del quadro e come piallato. Vedova, sedicenne, butta iconoclasta lo specchio ai suoi piedi e si ritrae dal sotto in su, ma come una colonna di forte arroganza, come uno
LA MARIONETTA MALVAGIA, 1976, olio su tela, 120 × 90 cm spiralico capitello gotico, che cresce come un vegetale forzato. Segno tradito di potente elevazione.
 narcisistico-costruttiva, Lattes no, anzi. Serpentinamente sbilenco, instabile, sempre. Come la sua psicologia pretende e protende. Perché l’universo di Lattes è narcissimamente pregno e velenosamente impregnato dalla sua stessa, satura fisionomia, scontrosa ed ostile.
narcisistico-costruttiva, Lattes no, anzi. Serpentinamente sbilenco, instabile, sempre. Come la sua psicologia pretende e protende. Perché l’universo di Lattes è narcissimamente pregno e velenosamente impregnato dalla sua stessa, satura fisionomia, scontrosa ed ostile.
Ed in fondo la sua pittura di fantasmi (e di complessi insolubili, di figlio che ha ‘ammazzato’ la propria madre, con il bisturi innocente del proprio stesso parto e ad ogni onomastico ritorna calendariale e funebre questa reiterata ed inflitta cerimonia della morte-rinascita morta) è ossessionata sempre, magari anche in larvata maschera fosca, dalla
sua presenza riconoscibile. Che avanza truccata, occultata ed immillata in miriadi varianti di vitrei riflessi, ma però ogni volta anche si sottrae, pittoricamente, si cancella, si svilisce, rinnegandosi al mondo, al verone della bell’immagine. Come il canto, già colpevole e smorto, al fiorire d’ogni crescente alba crepuscolare, del tradente galletto biblico.
E così anche lui vien giù, come un sacco che tracci l’aria, e l’impolveri. Spettacolarizzando la propria perenne, giudaica caduta-diaspora, depressiva. E quello ch’è decisivo, e caratterizzante, in queste tele, è che questa sua distanza melanconica e saturnina, non può che esplicarsi altro (ed anzi espiarsi) che in questa sorta di sempiterno, riallestito teatrino incendiabile, a scaffalatura e vivisezione compressa, popolato di mille altri ectoplasmi vaganti, esausti e torturati. Che s’agitano irrequieti e sperduti, e vagulano, in una questa sorta di desolato inferno, inchiostrato ed orfano d’ogni divinità.
Che poi incontreremo meglio nelle pagine 44 e 45, dove il riferimento non è soltanto, accecato e naufrago, a chissà quale ‘Isola dei Morti’, spaternizzata e denutrita di tinte simboliste, ma anche alla proserpica, sprofondata passeggiata dantesca, in un nebbioso e sulfureo ‘Senza Titolo’, e senza alcun fondamento di terreno, per sempre privo e sottratto d’ogni remissione e perdonanza. Come un Pinocchio ebraico, livido e cereo, dissanguato d’ogni vita, pubblica e privata, egli si mostra e cela lì, innumerato, appeso tra altre azzittite teste di legno. Che pure non gli lesinano intorno la loro sofisticata eleganza secessionista: il loro decorativo, fosforescente, bisbigliante e mosaicale puntinato sfondo oro. È come se volutamente si appendesse, storto, in questa specie mancata d’assopito serbatoio
di possibili drammaturgici, di incipit naufragati. Per vedere che effetto fa, al suo pretenzioso, immaginario pubblico strattonato.
La stessa sgorbiatura sghemba la ritroviamo in una tela dell’83, che lo rappresenta nel suo riconoscibile, ideale, archetipico non-luogo atelier, screziato, stemperato d’intarsi luminosi. Via Po, via Calandra, ‘Vecchio studio’ che ne sai, non importa: realissimo luogo immaginario, angusto spazio d’angustia.
Si guarda nello specchio di noi, che lo guardiamo, come se avesse ormai rinunciato a rappresentarsi, paradossalmente ancora rappresentandosi, come reiterando un vizio e una perversione. Gettata la spugna, che netta i colori dall’assassina coltellanza dei colori, gli occhi come bendati, la mano arresa sul corpo, sulla riluttante centralità aureolata della sessualità, come tacitata. Carezza ad un cane riottoso. La non-presenza dell’anima annerita dell’artista, in perpetua sottrazione, la si evince benissimo nella tela accoppiata, ove la sua evocazione in assenza, svestita, lo fa, per scommessa, apparire ancora più evidente, ‘chiamato’ per sineddoche progressiva: abbandonati sul tabouret di lavoro, nella furia del sottrarsi (di più: detrarsi) sciarpa, cappello, grembiule a rovescio – nell’ordine dello scappare – che sono poi gli strumenti ordinari del mestiere di vivere pittorico. Perché la sua pittura è sempre più un caparbio prendere le misure dell’aria e delle cose soffocanti, ma pur realizzanti, per lui: àncora e gancio, che gli si fanno intorno, affastellandosi.
Come nell’accoppiata delle pagine 18-19, l’onirica ‘Famiglia’, quasi schierata a battaglia soltanto vocale, per un muto autodafè, inesorabile e senza verdetto; ed accanto, le anime morte, disposte invece a coreografica scacchiera, in una sorta d’indecifrabile notturno veneziano. Incenerito. Ma l’uso perimetrato dello spazio è sostanzialmente lo stesso: come se l’interno (tramato da un perenne tappeto d’indistinguibile penelope, fiume di tessuti biografici,
che non smettono mai) fosse in realtà una piazza smisurata e pur claustrofobica. E, simmetricamente, l’esterno, perennemente ‘Senza Titolo’, fosse in realtà un appartamento decostruito e disossato, nel buio: cinereo spazio scenografico d’un campiello sfondato. Già altre volte, per Lattes, abbiamo suggerito quest’evidente parentela con strangolate situazioni kafkiane, irresolubili ed ormai soffocate, nella feroce bambagia del senza-tempo muto, questa specie d’eterno processo reiterato, di acefali ‘burattini’ interscambiabili, che rappresentano esemplarmente l’immutabile istituzione familiar-psicoanalitica, sia pur segnata da un bianco delittuoso, da una cancellatura clamante: una casella desolantemente e rumorosamente vuota. Quella della figura materna, femminile, strappata come un biglietto. Che poi diventerà bambola strepitante, o spaventata, come a pagina 33. Materializzatissimi fantasmi sfatti, che però puntualmente interrogano ed investigano e condannano, senza mai fornire la pergamena definitiva del verdetto, comunque liberatorio. Qui l’attesa si fa, vistosamente, morbidamente, morbosamente (infida
moquette senza fondo) un voluminoso, fiorito tappeto rimboccato e dilagante, che fuoriesce come dagli stessi giudici familiari, lunga barba ricamata di Matusalemme: rigurgito cagliato di neri immaroniti, letto cemeteriale, giardino di silenzi pesantissimi.
Come certi pavimenti trafficati d’ombre: tra notturni fiori ricamati di proiettili appiattiti. Summa di liturgie ricorrenti: interrogazione scolastica, convocazione paterna, contesa coniugale, consiglio aziendale – non importa. Importa quell’ansia di condanna mancata, che si fa e si gonfia, in tappezzatura di ciniglia.
Tappeto di notte e di barlumi, invece, per il ‘Senza titolo’ e Senza Data 80 per 100, che abbiamo accoppiato a pagina 19, proprio per indagare ed evidenziare quest’indifferenza lampante alla sostanza rigida delle pareti, che forse gli viene dallo spaesamento dei mobili nel paesaggio, di Savinio e De Chirico. Solo che la metafisica, con lui, perde di chiarezza architettonica, piacentiniana, littoria, e si fa sfusa, spettrale, fantasmatica: larvale ed impaniata di lame di buio. Ogive veneziane, sospetto di campiello, arcate cieche, sinopia d’un infantile gioco di palla sospeso. Inudibili dialoghi mozzati, morsicati dall’arsura dell’inchiostro di china, simulata all’olio. E tanti altri notturni sinistri, come l’evitabile ‘Invito a Citera’, senza più partenza: attraccato. Un ballabile spento, cinereo invece che citereo, incipriato, alla Watteau, ma ancor più immalinconito, annerito, immerso nel buio senza mattino, incatramato di pece sulfurea: i corpi che rilucono, di nuovo spettralmente, e come spesso, una piccola bava di sangue rosso, a firmare e fermare l’incantesimo.
Venezia? Laguna? Sipario dipinto? L’importante è sapere che non sappiamo dove siamo. E l’‘esterno’, decostruito come una scenografia teatrale, smontata, non è più nemmeno all’esterno. È in un limbo di esattissima indefinibilità. Perfino le coppie hanno smarrito la loro sessualità, Adamo sta solo con Adamo, raddoppiato su una battima di laguna, che non ha più nemmeno il soccorso marcio di quell’acqua melmosa, da cui, altrove, prendevano vita ed agonia i fantocci rotti di quell’espanso, carillon senza carica, che diventa la sua intermittente pittura a riverbero. Cordone ombelicale, che non ha ancora trovato le sue forbici al bivio. Adamo sta solo, eppure ha bisogno di un legame, un legante, un allaccio, come tante figure della solitudine di Lattes. In due si sta peggio, e i gruppi si formano e si sformato: tiptologica tipografia deforme del vivere, del vivacchiare.
Che ci si metta anche al riparo, nel fragile paravento della casa-biblioteca, che conta? La figura che cuce, inutilmente, fiabescamente, come una campana di vetro d’incomunicabilità, parca tagliata, non giungerà mai alla fine del proprio lento, midollare discorso filato. E le figure, nell’étagère stipato della vita, non compiono altro che gesti incantati, meccanici, reiterati: prossemica impazzita e senza più interlocutore. Si fanno, progressivamente, via via più bambole, marionette, manichini. Non distingui più la figura vera, annichilita nelle poltrone di contenzione, dalla vivacissima prolificità di tutte quelle marionette, che s’infittiscono e crescono: piccole donne di cencio, pepinière di risentimenti intagliati.
Sotto la luce illividita di complici abat-jour. Che non son più corrive allusioni a canzonette orecchiabili, ma accecati avatar di tappezzerie pittoriche, alla Vuillard o alla Vallotton, chiazzate di luci malate ed acerbe: nebulosi fari del malessere, alla Baudelaire, laghi di luce inarrestabile, tra le occhiate impermalite degli specchi, che cancellano però la stessa fisionomia disfatta del volto, che s’affaccia al loro cospetto. Inutile specchio di vanità svanente.
Le scansie, le librerie, gli ‘Scaffali’, sono in fondo saturati schedari anagrafici, tra conchiglie alla Calandri, allucinate maschere di Ensor, sospetti di felini e poi vedove trine e pizzi, da antiquata merceria polverosa alla Bruno Schultz (ma le vetrine sono anche le stesse, drammaticamente assassinate a sassi, dei pogrom nazisti). La passione collezionistica, compulsiva, come autoritratto diffuso, infuso. Nella notte le maschere scricchiolano, riacquistando polemica, sovversiva vitalità. E le movenze insaccate sono in fondo le stesse delle biascicate cerimonie in Sinagoga.
Quello che conta, tra teschi e marionette, è il filo teso, tra la vita e la morte, che non ci lascia mai, anche cadaveri. Siamo appesi, impiccati, al nostro non-destino di ognuno. Talvolta distesi, arresi, atterrati, atterriti, azzerati. Anche dalle fedine gogoliane dell’ironia.
La vita diventa uno scaffale, o un postribolo, alla Fausto Pirandello, o al ‘Sang d’un poète’ di Cocteau, ridisegnato come un night club di Mollino: si sale e si scende, per rimanere immobili. Anche quando le lingue di fuoco d’un incendio epocale, lambiscono i sipari della scena, intasandola d’un rosso arroventato, di spiegata spettacolarità sopranile. Si grida, si strepita, ci si dimena, ma si rimane: ‘Bambole’. La voce non ha più presa. Afono spavento di stoppa.
La fuga nei ‘Giardini Cavour’, risorgimentalmente innocui, non risolve nulla, in verità non si evade mai, ci si getta soltanto dal balcone dell’irresolutezza protratta e sgomenta. Come un direttore d’orchestradittatore, alla Canetti, improvvisamente impazzito, il probabile Artista misura, come sempre, lo spazio e dirige l’aria, perimetrando il vuoto.
Lo vediamo di spalle, ma non ha senso chiedergli di piroettare verso di noi, per gli applausi. Perché la sua identità è ormai abrasa, tarlata, lo sappiamo, sbiancata ed annerita ad un tempo, da una fonda risata nicciana, che squaglia dionisiacamente l’identità annichilita. La follia nitrente della riproducibilità pittorica, che non ha più nemmeno
un cavallo da abbracciare, o da cavalcare. Vivibilità azzoppata. Il gesto direttoriale-dittatoriale, subito disperato, è quello stesso del Cristo, che benedice ma insieme si arrende, umanamente sconfitto, al suo destino obbligato. Gesto di presa di posizione, ma anche di resa abbracciata: l’aria vizza dello spazio si brucia, nello spazio d’una piccola tela masticata. Le figure disposte di schiena, che negano a noi il loro volto negato, non hanno più il significato romanticofridrichiano- mistico della ‘siepe’ d’inciampo, che dà la misura dello sconfortante e sconfinato infinito.
Ma al contrario è il segno di un’arrendevolezza urlata, rauca, sgominata e sgomenta. Incendiata dal sole nero della melanconia assoluta, che domina tutta la scena, come un pugno violento di petrolio. Il diavolo diventato un militare paonazzo, costretto a salutare soldatescamente un Potere, che si è squamato come un negro fuoco fatuo. Spento.
Ed è il momento in cui il gusto, chiamiamolo così Galatea, appunto, mescolando Ensor, Odillon Redon, Bellmer, Moreau, ma anche un certo tipo di surrealismo alla piemontese, alla Surfanta, da cui si è tenuto discosto, Colombotto Rosso, Léonor Fini, Abacuc, Stanislao Lepri, viene a sfibrare ogni forma e fisionomia, a condensare e sciogliere la luminosità, scheggiata e lebbrosa. Calchi a contatto, quasi carte di varese allucinate, da nebbiosità religiose e bigotte, parrocchiali: mitre, pastorali, aureole, ostensori. Persino il gatto appisolato del teschio, ha trovato una sua cuccia-capitello. Morbidissima.
Mentre gli spettri che progressivamente abiteranno il suo vuoto, ritrovano pupille invasate ed anatomie corrotte, deformi, trasognate. Tra brucianti fenici notturne e volti decapitati, sospesi ed inseriti nelle loro gabbiette, sprofondante nel delirio liquido e fiammante di forme bluastre e venose, accecate.
La conchiglia come brace ghiacciata.
E il volto, in tutto questo concime materico e stemperato? Avanza spesso, se conserva ancora una fisionomia, armato da una macchina-corazza annodata di dita-artiglio, che ricordano i nudi di Schiele e le anchilosate fotografie di mani arruffate e piangenti, parlanti, che il fotografo Trcka gli ha dedicato.
Ma l’esito è comunque baconiano, storia finale d’un volto tumefatto e boxato, che aggalla verso di noi acefalo, abraso, cancellato nei tratti: sigillo accecato di un io rotto, che ha troppo cercato se stesso, e che in questa veronica piallata si riflette nel nulla riverberato nel lusso della materia.
MARCO VALLORA
Recommended Posts

Al Meis di Ferrara, due opere di Mario Lattes
Marzo 29, 2024

I mondi di Mario Lattes #2
Luglio 11, 2023
Questo contenuto non è visibile senza l'uso dei cookies.
Questo contenuto non è visibile senza l'uso dei cookies.
Utilizziamo cookies per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Leggi la nostra Cookie policy.
Clicca su "Accetta cookies" o continua la navigazione per consentirne l'utilizzo. Potrai in qualsiasi momento revocare il consenso usando il pulsante "Revoca consesno ai cookie" nel piede del sito.